Urban rooms: la nuova sfida dell’architettura biofilica


Nell’era contemporanea molte città si ritrovano ad affrontare la problematica della convivenza tra urbano e paesaggistica con l’amara conseguenza che l’urbano, nella maggior parte dei casi, finisce per deturpare, assorbire, modificare, o ancor peggio, annullare tutto quello che c’è attorno in natura. È qui che entra in gioco l’architettura biofilica e le così dette stanze urbane. Le urban rooms sono “spazi in-between” tra architettura e territorio che diventano luogo di osmosi tra volumi architettonici e spazi naturali del contesto collocabili sia all’aperto che al coperto. Da diversi studi è emerso che essere circondati dalla natura, rende più concentrati, creativi, sani, felici.
L’architettura biofilica si pone come obiettivo quello di restituire all’essere umano la condizione primordiale di vivere a contatto con la natura e la sfida è quella di progettare edifici tanto intelligenti quanto rigenerativi. È la nuova sfida che vedrà come protagonista Welcome, l’edificio biofilico che sarà edificato a Milano, come versione moderna della sede Rizzoli, progettato dagli architetti Mancuso e Kengo Kuma Associates, promotori dell’architettura organica. Il progetto punta alla realizzazione di un luogo di lavoro che dia anche possibilità di svago e benessere grazie all’inclusione di una piazza aperta alla città, ricca di vegetazione, serre, terrazze e orti e grazie alle corti open air.
Altri esempi di architettura biofilica sono:
L’architetto, che sceglie di credere nei progetti urbani di architettura biofilica, dovrà necessariamente avere un approccio innovativo e creativo per poter migliorare in modo sostanziale le condizioni urbane di una città o di un edificio. Per la riuscita di questi progetti, inoltre, è importante che l’architetto si preoccupi di individuare le strategie politiche, economiche e sociali per assicurare che le soluzioni urbane e architettoniche siano responsabili. Le urban rooms sono, quindi, considerate strumento di ordinatore e di connessione tra spazi verdi e spazi architettonici, e di collegamento e d’incontro che garantiscono la riqualificazione anche d’interi settori urbani. In questo modo l’architettura diventa un valore aggiunto alla natura e non un elemento di disturbo o distruttore che contribuisce al miglioramento della vita delle persone e dell’ambiente, conservandone la sua natura più pura.








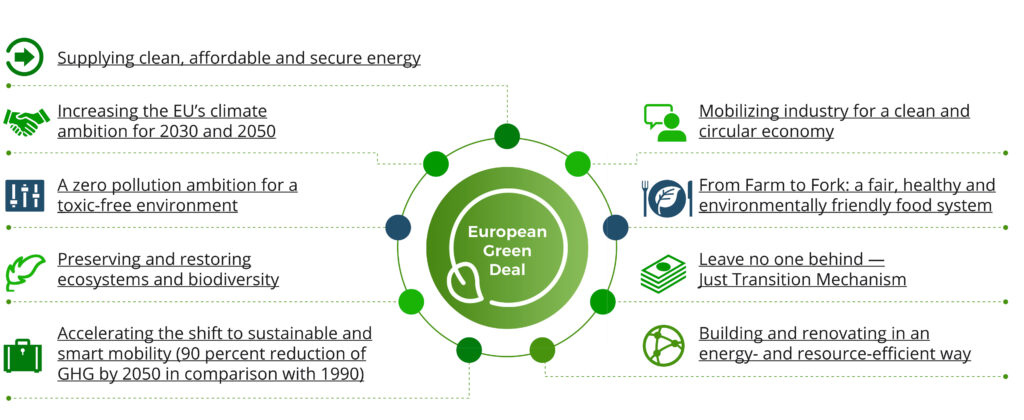







Risposte